Gli scritti del “Menico”: Gastronomia tiranese
CULTURA E SPETTACOLO - 26 11 2020 - Ivan Bormolini
Eccoci al secondo appuntamento con gli scritti del “Menico. In questo caso il “sciur Dutur”, come in tanti lo chiamavamo, ci porta a fare un viaggio nella gastronomia tiranese. E' questo uno scritto molto dettagliato e descrive com'erano le cucine e l'alimentazione contadina di un tempo. Non solo in questo articolo il Dottor Corvi annovera tradizioni che oggi paiono cadute nel dimenticatoio, l'arte di allevare e poi confezionare il maiale tra le rustiche case e ci narra pure del pane e di come veniva preparato. Non mi dilungo oltre e vi invito alla lettura, il tutto è una riscoperta di alcuni piatti che nel nostro tempo, per la loro semplice bontà, dovrebbero tornare a far parte della nostra dieta. Ivan Bormolini (Di Domenico Corvi) Consultavo giorni fa un testo di dietetica: oggi van tanto di moda le diete controllate, la macrobiotica, le diete ipoproteiche, il conteggio rigoroso delle calorie, le cure dimagranti e così, quasi inconsciamente il pensiero mi è corso a come si mangiava una volta al tempo della mia fanciullezza in cui ognuno mangiava soltanto ciò che passava il convento e tutti stavano bene e la vista del medico era un fatto eccezionale, da ricordare per parecchio tempo. Va bene che non esisteva neanche la Mutua ed i soldi per le medicine costituivano un vero sacrificio, però io amo credere che fosse questa sana, anche se poco varia alimentazione, unita alla vita all’aria aperta, a conservare la buona salute. Allora i problemi di linea non esistevano e l’unico vero impegno era quello di mettere insieme il desinare con la cena. La dieta variava soltanto in rapporto alle possibilità economiche, che del resto non differivano molto da una famiglia all’altra, fatta eccezione per i pochi ricchi: i cosiddetti “sciur” . La vera dieta la stabilivano le stagioni. Nella nostra società quasi esclusivamente contadina, l’alternarsi delle rivoluzioni del nostro pianeta stabilivano il succedersi pressoché fisso del menù. Si sarebbe potuto stabilire all’inizio dell’anno con una buona approssimazione la lista delle vivande di un intero anno. Per quel che concerne le carni era il maiale che ne costituiva la quasi totalità ed il consumo delle sue parti seguiva un rituale fisso stabilito anche in base alle esigenze dell’agricoltura in quanto che c’erano delle scadenze fisse che coincidevano con la fienagione, con l’alpeggio, con la mietitura. Il giorno del sacrificio del maiale, allevato per altro con infinito amore da parte della massaia cui questo compito spettava di regola , venivano prelevate immediatamente le frattaglie, vale a dire il cuore, il fegato, la milza, i reni ed i polmoni che venivano consumati nei due o tre giorni seguenti che erano anche quelli destinati alla frollatura delle carni; solo parte del fegato veniva lasciata da parte per essere utilizzata nella confezione delle mortadelle, dette appunto di fegato. I modi di cucinare queste parti erano diversi: il cuore era riservato alle donne di casa che preparavano così la “minestra de ris e cör”, come pure il cervello che veniva fritto in polpette in cui veniva impastato anche del pane grattugiato ed un tuorlo d’uovo. Fegato e polmone, tagliati a pezzettini e fritti con cipolla costituivano l’ingrediente principale per la “ pulénta e fritüra” ; il rene o “ rugnùn” era cucinato nel tradizionale modo vale a dire trifolato, col prezzemolo. La coda ‘l cuin” e le zampe “ ‘l pesciö” mescolati a cavoli ed a pezzi di cotenna, servivano per la “verzàda” o “cazzöla” secondo le varie denominazioni , un po’ diverse da paese a paese nella stessa valle. Il resto delle cotenne veniva utilizzato nella confezione di “cudeghìn” e cudegòt” diversi tra loro solo per il diametro del budello usato e per il periodo di conservazione. La cute del muso, con il connettivo ed il grasso sottostante, era impiegata per i “salàm de testa “, anche questi da conservare. Sistemate così le parti meno pregiate, si provvedeva alla insaccatura delle parti nobili: le salsicce ed i salami. Bisognava ancora distinguere fra “ lüganéghi de prima”e “lüganéghi de sanch” impastate queste ultime con il sangue stesso del maiale fatto bollire e mescolato a pezzi di lardo ed a qualche rimasuglio di carni di scarto. Il tutto, dopo una prima scorpacciata libera a tutti i componenti della famiglia. che aveva luogo alla sera della maciglia, veniva sapientemente dosato dalla massaia nei mesi seguenti, che permettevano alle salsicce di passare attraverso i successivi stadi di “misòlti” e quindi di “ sèchi”. Per il salame che veniva consumato nell’arco di quasi tutto l’anno, particolare riguardo veniva riservato al “ cülàri” detto anche “salàm de ‘l batésim”, insaccato nella parte terminale dell’intestino e quindi più grosso e che veniva conservato proprio per qualche battesimo che , data la struttura patriarcale della famiglia e la prolificità dei nostri antenati , non mancava quasi mai nell’arco dell’anno. Restavano poi le parti più pregiate e quindi da consumarsi solo in particolari occasioni vale a dire i “persüt”, le “ bundiöli “ed infine .anche se meno apprezzate le “panzèti” . Per quel che concerne le pancette, piatte ma per lo più arrotolate, venivano consumate in occasione della prima fienagione, vale a dire alla fine di maggio e costituivano la “ culaziùn” e la “marénda dei “ segadùu” . Quali materie di ricupero, ma non per questo meno apprezzate, restavano le ossa che, data la difficile conservazione, venivano consumate nella prima quindicina dalla maciglia e sempre accompagnate da voluminose pentolate di patate lesse. Restavano ultimi, i “rustèi” cioè i resti sul fondo della caldaia della bollitura del lardo che serviva a preparare il “cusc” o strutto, che solo o mescolato al burro avrebbe costituito il condimento per friggere quasi tutte le vivande. Sì, perché i nostri contadini producevano il burro ma non potevano permettersi il lusso di mangiarlo e quindi preferivano, o meglio erano costretti a venderlo ai signori per ricavare quei pochi soldi che servivano per andare a “ la butéga” a comprare i generi di prima necessità . Per il resto l’alimentazione era costituita da “chisciöi”, enormi frittelle di farina di saraceno, o a volte anche di frumento, con inserite in mezzo della larghe fette di formaggio filante; “ pizòcher” , tagliatelle pure fatte con la farina nera e poi la polenta in tutte le sue varietà di “ giàlda “ o di farina di mais”, négra” o di farina di grano saraceno e ultima la “mùgna” risultante da un ibrido fra le altre due. Per la nera esistevano poi le sottospecie della “taràgna” in cui entravano anche burro e formaggio, destinata alle grandi occasioni; la “pulénta cùscia” cioè condita con formaggio e burro fritto versato sulle fette già tagliate , ed infine la “ pulénta an fiùu” o fatta cuocere nella panna fresca che si cucinava quasi esclusivamente sugli alpeggi dove il latte abbondava. Questi per lo più erano i piatti di mezzogiorno ; la sera la cucina era assai più parca: una minestra e poi pane e formaggio e salumi. Il tipo di minestra variava a seconda delle stagioni: dai ricchi minestroni dell’autunno quando la verdura c’era in abbondanza, alle minestre a base di latte dell’inverno. Tra queste ultime , il “ris e lacc” , cioè il riso passato nella farina di frumento e cotto nel latte, alla “ pàpa de munt”, vale a dire un impasto di farine bianca e gialla cotto sempre nel latte; alla “ farinàrsa”, impasto di farina fritto nel burro. Naturalmente il latte era uno degli alimenti più diffusi anche perché prodotto in maggior abbondanza ed a costi bassi. Durante l’autunno, un nuovo alimento entrava di prepotenza nella dieta: la castagna , che spesso costituiva l’unico piatto disponibile . Anch’essa veniva cotta in diversi modi: dalle comuni castagne lesse , o “ferüdi” , ai “castrùn”, o castagne bollite solo parzialmente sbucciate, alle “ pelàdi”o castagne bollite senza buccia; a queste ultime due qualità nella cottura si aggiungeva anche un pizzico di anice , e potevano essere mangiate anche in una specie di zuppa di latte. C’erano poi, anche se non molto usate, data la scarsità di cucine economiche, i “ biscòt”, o castagne cotte nel forno ed infine, quelle che comportavano una specie di rito tuttora in uso : i “ braschée”, che radunavano attorno al focolare numerose brigate ed erano sempre innaffiate da abbondanti bevute di quel vino asprigno ma stimolante prodotto dai nostri ridenti vigneti. Sì, perché il vino, assieme al magro formaggio di “caséra”, era uno dei pochi elementi che ben raramente mancavano sulle tavole dei contadini. Anzi, già nella prima infanzia le madri solevano staccare di tanto in tanto il lattante dal seno per infilagli tra le labbra qualche cucchiaio di vino che, secondo le credenze del tempo, doveva servire a dar vigore e salute. Il pollame, come del resto anche le uova, servivano per lo più per essere tramutate in denaro per le piccole spese. Il pane veniva preparato dal “ prestinè” cui si portava la farina ed il sale e si lasciava una certa quantità di pane quale ricompensa per la mano d’opera. A seconda della esigenza della famiglia, si commissionava una “còcia” corrispondente a trentasei chili, oppure “mèzza còcia” o un “ pés”, vale a dire otto chili. Esistevano poi dei piatti speciali da usarsi esclusivamente in caso di malati o di puerpere in corso di allattamento. Fra questi erano il “ pandrìd” o suppa di pane grattugiato con aggiunta di burro e magari anche di qualche cucchiaio di olio di oliva ed il “ pancòt” in cui il pane veniva cotto così com’era. Per questi commensali particolari si poteva anche andare dal “bechée” ad acquistare un “ “girèt de vedèl” o un pezzo “de biancustàa”. La domenica e i giorni festivi, spesso si faceva il lesso per tutta la famiglia, in modo di avere il brodo anche per la sera e spesso la carne era costituita da una “cràpa de bar”o da una “cua de manz”, cotte con l’aggiunta di una cipolla, una carota ed una “gamba de sèdan” , per dare il sapore al brodo, che si poteva anche sorbire tagliato col vino. Sempre il vino si beveva associato al latte nella “cadùlca” o, come ricostituente e dissetante, assieme a uova sbattute e zuccherate nella “rüsümàda” . Questo grosso modo gli alimenti in uso conditi con molto appetito e molta buona volontà, in un tempo in cui le sofisticate ricette dell’Artusi, unite al “boom” economico non erano ancora riuscite ad impigrire gli stomaci e a creare le dispepsie. Anche il rituale della mensa era molto semplice, anche se rigorosamente rispettato: prima si servivano i vecchi e i bambini, con particolare rispetto al patriarca ed ai neonati, poi toccava agli uomini ed infine alle donne , che in parte mangiavano in piedi , per essere sempre pronte a servire. Gli ultimi ad essere serviti erano i “ bàrba “ e le “amàde” cioè gli zii e le zie non sposati ed infine i lavoratori a giornata. Tutto molto semplice quindi, all’insegna della parsimonia. Una cosa sola non mancava: la disponibilità di tempo e la buona armonia che sono senz’altro il miglior condimento di ogni cibo e che riescono a far entrare il sole anche nei tuguri più bui e più anneriti dal fumo, nei quali però non entrano le nevrosi e le meschinità dei tempi nostri. FONTE: IL TIRANESE N° 5 gennaio febbraio marzo 1977. Cooperativa Editrice Tiranese viale Italia 91 23037 Tirano. Stampa: Tipografia Bonazzi via Mazzini 23100 Sondrio
Gastronomia tiranese


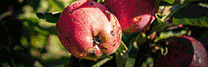







LASCIA UN COMMENTO:
DEVI ESSERE REGISTRATO PER POTER COMMENTARE LA NOTIZIA! EFFETTUA IL LOGIN O REGISTRATI.
0 COMMENTI