Processo a Caterina Ross: intervista alla regista Gabriella Rosaleva
CULTURA E SPETTACOLO - 12 01 2022 - Hans-Jörg Bannwart e Giovanni Ruatti
Nel ricco programma culturale della Valposchiavo il 2021 è stato anche l’anno della rassegna “Streghe!”. La manifestazione, svoltasi da maggio fino a ottobre, ha portato alla ribalta la storia dei processi di stregoneria nella nostra regione, il loro lascito fisico, morale e psicologico all’interno della nostra società, e il mito legato alla letteratura e alle credenze. Numerosi sono stati gli appuntamenti, in presenza e sul web, compresa anche una pubblicazione cartacea, realizzati grazie alla collaborazione di Pgi Valposchiavo, Valposchiavo Turismo, Museo poschiavino, MF Video GmbH, Scuole comunali di Poschiavo, I Film di Devon House, Festival delle erbe spontanee, l’artista Ulrike Streck Plath e il grafico Mauro Lardi. Nel complesso sono però state diverse le persone e i gruppi che hanno aiutato alla realizzazione dei diversi progetti portando le loro esperienze e competenze, la loro forza lavoro, e che meritano per questo motivo un grande applauso. La rassegna è inoltre stata resa possibile grazie al sostegno della Promozione della Cultura Comune di Poschiavo, Promozione della Cultura Cantone dei Grigioni, Comune di Brusio, Ufficio per l’economia e il turismo, Banca Cantonale Grigione, Repower L’energia che ti serve, InfoRlife SA, Saponeria Wanda, Casa Vinicola Triacca Millesassi, Plozza Vini, Tipografia Menghini, Fondazione Ernst Göhner, Fondazione Willy Muntwyler, Fondazione Boner für Kunst und Kultur, Fondazione Oertli, Fondazione Stavros Niarchos. Per chiudere ufficialmente la rassegna proponiamo l’intervista a Gabriella Rosaleva, regista del film Processo a Caterina Ross (1982), proiettato presso il fienile di Devon House di Poschiavo nell’ultimo appuntamento in programma.. La pellicola, emotivamente forte, ha sollevato da parte del pubblico diverse domande che in parte i curatori di quest’intervista, Hans-Jörg Bannwart e Giovanni Ruatti, hanno raccolto e posto alla regista. In quest’occasione è riportata una versione ridotta del colloquio che verrà pubblicato integralmente sui prossimi numeri dei «Quaderni grigionitaliani». I processi per stregoneria hanno interessato tutta l’Europa, dal Medioevo fino a metà Settecento. Che cosa l’ha spinta a trattare proprio di un processo celebrato a Poschiavo e, in particolare, quello a carico di Caterina Ross? Ai tempi ho letto con interesse La signora del gioco. La caccia alle streghe interpretata dalle sue vittime della filosofa Luisa Muraro che ha raccolto, commentato e analizzato diversi verbali dei processi di stregoneria. Tra questi casi mi ha colpito quello di Caterina Ross: rispetto ad altre testimonianze lei non ha denunciato nessuno, nemmeno sotto tortura! Infatti, alla domanda di confessare le compagne e i compagni di berlotto (sabba), lei non ha mai pronunciato un nome. L’ho trovato di una grande dignità e superiorità rispetto a quello che avevo letto su altri processi. Alla fine Caterina dice, alzando la testa: “Mia nonna si chiamava Regaida I, mia mamma Regaida II e io mi chiamo Regaida III”, ma non afferma mai di essere una strega. Il film colpisce per l’attualità nei contenuti e per il linguaggio sorprendentemente contemporaneo, anche se il processo si svolse nel 1697 e sono trascorsi quanrant’anni dalla creazione di questa pellicola. Possiamo dire che è un film senza tempo. Quali ne sono gli ingredienti? Prima di tutto ritengo che ci debba essere del coinvolgimento e della passione nei confronti della materia e della protagonista. In secondo luogo, è fondamentale il desiderio di essere onesti, di essere aderenti a quello che si sa e a quello che si è capito di lei. In terzo luogo, è importante essere molto semplici. Non è però facile cercare la semplicità e far capire al contempo tutto quello quello che vuoi dire. Per esempio, nelle inquadrature non ho mai aggiunto niente di troppo. Eppure l’immagine non è mai sciatta, perché è sempre molto elaborata e calibrata nello spazio. Il mio è un cinema scarno, è un cinema di emozioni. Per quanto riguarda i dialoghi ho preso testualmente i verbali del processo. Non ho cambiato una virgola. Come la critica di quei tempi definì questo film? Il film partecipò al Festival di Locarno nel 1982 e vinse il Premio della critica. E per quanto riguarda la distribuzione, dov’è passato? È passato nei cinema d’essai. Quarant’anni anni fa era effettivamente un film abbastanza anomalo. Per le sue particolarità artistiche ha però avuto un percorso prestigioso e un’enorme diffusione nelle facoltà di cinema in varie università americane, soprattutto a New York e dintorni, ma è anche passato nelle università della California. È stato per una settimana al MoMA, museo d’arte contemporanea di New York, nel 1983. È facile giudicare questo film come un’opera di denuncia femminista. Lo è stato nelle intenzioni iniziali? Quando è uscito il film, si parlava di un parallelo al femminismo di quel periodo. Io non ho avuto questo pensiero. Certamente, essendo donna, qualcosa sarà pure trapelato, ma non sono partita con quest’intenzione di fare un film di denuncia concentrandomi sulle istanze femministe. Veniamo ai contenuti del film. La vicenda vera e propria è preceduta da un esteso prologo: l’arrivo del podestà, di cui nel film non si vede mai il viso. Prima lo vediamo come passaggero in un veicolo che lo porta in montagna, poi lo vediamo salire lentamente le scale del capannone abbandonato in cui avrà luogo il processo. Qual è il significato di queste scene? Desideravo partire dallo sguardo di oggi, quindi su un auto, e percorrere una strada piuttosto contorta, difficile e lunga per raggiungere il posto del processo. Io avevo presente un’idea ben precisa di tribunale: un tribunale corrotto, distrutto, in sfacelo, dove l’autorità ha una mano pesante fino a condannarti a morte. Un tribunale potente e terribile. Il punto di forza della storia è che il podestà parla e non si vede. In questa maniera volevo far passare il messaggio che le atrocità vengono sempre nascoste. Il processo si svolge in totale isolamento, in un contesto industriale. Si tratta di un capannone abbandonato della Stazione Nord di Milano, alla Bovisa, la vecchia Montedison. Il contrasto con le inquadrature di paesaggi montani, precisamente della zona di Pedenosso in Provincia di Sondrio, è certamente netto ed evidente. Nel cinema è lo spettatore che mette in moto il film e fa le proprie associazioni personali. L’immaginazione della regista non segue una vera logica. Il film si avvantaggia di un linguaggio simbolico e surreale. Il rumore dei treni che passano nelle vicinanze sembra sottolineare l’isolamento all’interno del capannone: i passeggeri di quei convogli non sanno cosa sta succedendo nello stabile. Sembra essere un processo in incognito. Quando vieni torturato e preso prigioniero, sei quasi sempre in un luogo estraneo. Le torture avvengono sempre in incognito. Sono sempre nascoste e in posti che il comune cittadino non immagina. Risaltano alcuni inserti intercalati nello svolgimento del processo vero e proprio, come quello dei lettori di giornale in una sala d’aspetto, l’intervento di una donna davanti a una stazione, o le testimonianze dei compaesani, in piena natura, in montagna. Che cosa ha voluto esprimere con queste scelte? Quei lettori stanno leggendo gli articoli in cui è scritto che Caterina è stata condannata e messa al rogo. La donna che sta alla fermata della Ferrovia Nord mentre il treno si ferma, dice: “L’hanno condannata nonostante Caterina dicesse di essere innocente”. Quella è una donna qualsiasi che seguiva il caso Caterina Ross, come noi abbiamo seguito negli anni scorsi il caso di Giulio Regeni o la detenzione dello studente Patrick Zaki. È tutto molto contemporaneo sia per quanto riguarda l’oggi, ma anche per quello che riguarda il domani, perché domani sarà sempre la stessa storia. Non cambia niente, se non i mezzi. Sembra che in questo film Lei abbia voluto penetrare nel clima emotivo di quelle situazioni coercitive senza però essere di parte. Vorrei fare un appunto sul mio cinema. È un cinema aperto, che lascia aperte diverse questioni. Io vorrei che lo spettatore decida da sé, si faccia la sua storia e rifletta senza condizionamenti e guide. In questo film mi sono calata in quel tempo, mi sono messa nei panni di quella donna, tutto qui. Una domanda che si pone il valposchiavino guardando il film è il perché le riprese non sono state girate a Poschiavo. Poschiavo è sempre presente nei testi del film. Il verbale del processo è ripreso pari pari. C’è una realtà dei fatti; però ci sono anche le scelte della regista, come per i luoghi di ripresa che devono essere funzionali alla storia come l’ho creata. Hans-Jörg Bannwart e Giovanni Ruatti


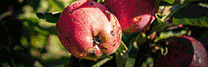







LASCIA UN COMMENTO:
DEVI ESSERE REGISTRATO PER POTER COMMENTARE LA NOTIZIA! EFFETTUA IL LOGIN O REGISTRATI.
0 COMMENTI